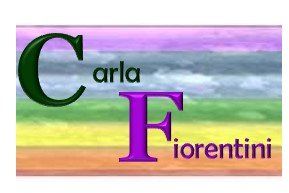Dottore, mi ascolti!
Ascolto riflessivo

Storia
Buon Giorno, dottore. Sono veramente a pezzi.
Buon giorno. Cosa le è successo? Cosa si sente?
È cominciato un paio di settimane fa. Pensavo non fosse niente di grave, così ho lasciato perdere, ma adesso non ne posso davvero più. sono piena di dolori al collo, alle spalle e allo stomaco.
Ricapitoliamo, magari non è nulla di grave. La situazione è cominciata circa due settimane fa. Ora lei ha dolori al collo, alle spalle e allo stomaco. C’è altro?
Sì. A dir la verità ho dolori sia al collo che alle spalle, ma soprattutto al collo. Poi mi sento sempre stanca, come se non riuscissi a dormire, ma non è vero.
Quindi lei ha dolori soprattutto al collo, si sente stanca come se non riuscisse a dormire, ma dorme.
Sì, dormo, ma forse non abbastanza, o non abbastanza rilassata. Sicuramente è un periodo difficile, in ufficio la situazione è molto tesa, e io ne risento, come tutti.
Stiamo facendo progressi. Lei non dorme abbastanza, o forse non abbastanza rilassata, ed è un periodo difficile in ufficio, dove la situazione è tesa.
Domande
Vi ricordo che dal punto di vista clinico questi casi sono totalmente inventati e fantasiosi. Esaminate solo, ed esclusivamente, gli aspetti comunicazionali!
- Il medico utilizza una tecnica di comunicazione ben precisa. Quale?
- A cosa serve esattamente questa tecnica?
- Ci sono avvertenze o raccomandazioni all’utilizzo di questa tecnica?
- Dal punto di vista della comunicazione, è consigliabile che il medico continui con la tecnica scelta o è opportuno fare dei cambiamenti passando ad un’altra tecnica? Eventualmente, quale tecnica di comunicazione suggerite?
Risposte
Il medico utilizza una tecnica di comunicazione ben precisa. Quale?
- Il medico sta seguendo la tecnica dell’ascolto riflessivo.
A cosa serve esattamente questa tecnica?
- Questa tecnica pone attenzione a tutto il messaggio, e il messaggio stesso viene usato per chiarire ciò che il paziente ha detto. In pratica chi ascolta è una cassa di risonanza di chi parla e l’ascoltatore riflette, come uno specchio, le idee e le parole dell’interlocutore. Questo tipo di ascolto è spesso quello usato da psicologi e psichiatri poiché chi parla è costretto a prendere consapevolezza di ciò che dice.
Ci sono avvertenze o raccomandazioni all’utilizzo di questa tecnica?
- L’ascolto riflessivo ha una componente di indagine, tant’è vero che viene utilizzato in ambito psicologico. Chi parla si trova riflesso nelle risposte di chi ascolta, che non usa più lo stesso filtro o parafrasi e metafore per evidenziare la comprensione e aggiungere qualcosa al dialogo, ma ripete esattamente le stesse parole, modulando la comunicazione paraverbale.
L’ascolto riflessivo presuppone che l’ascoltatore guidi il dialogo e il suo ruolo di guida deve essere riconosciuto e accettato da entrambe le parti. Se manca una di queste condizioni chi parla può facilmente sentirsi preso in giro.
Inoltre nell’ascolto riflessivo l’ascoltatore deve avere piena padronanza del proprio sistema di comunicazione paraverbale ed essere perfettamente in grado di non giudicare, elemento molto difficile da applicare in alcune situazioni.
L’ascolto riflessivo è la forma migliore di ascolto per l’applicazione del metamodello
Dal punto di vista della comunicazione, è consigliabile che il medico continui con la tecnica scelta o è opportuno fare dei cambiamenti passando ad un’altra tecnica?
- Il medico potrebbe anche condurre l’intera anamnesi con questa tecnica, ma probabilmente ci vorrebbe un tempo lunghissimo per ottenere informazioni sufficienti e soddisfacenti.
In alcuni casi l’inizio del dialogo tramite ascolto riflessivo è utile: il paziente si ritrova ad essere praticamente sempre d’accordo con ciò che dice il medico e annuisce costantemente, e ciò crea un buon livello di empatia e complicità, ma poi conviene passare ad altra tecnica, o almeno introdurre alcune varianti.
Eventualmente, quale tecnica di comunicazione suggerite?
- Sicuramente l’ascolto attivo, arricchito da domande strategiche che, tramite una gestione ad imbuto del dialogo, portino il paziente ad identificare i punti focali su cui il medico potrà intervenire.
.

Non so come si insegni la storia oggi. Ai miei tempi, parecchi anni fa, la storia era una favola affascinante, ricca di personaggi, o una sequela di date: dipendeva dall’insegnante. Ma era sempre nettamente separata dall’educazione civica (che, bisogna dirlo, era piuttosto trascurata e, quando l’insegnante si ricordava, consisteva solo nella lettura della Costituzione: meglio di niente, ma troppo poco per educare dei cittadini). Certo, l'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato, quindi non deve necessariamente preoccuparsi di sviluppare cittadini educati, ma solo informati. Non so neanche se l’insegnamento si chiami ancora Storia ed Educazione civica. Però credo che, attraverso l’insegnamento della Storia, si possano formare le coscienze, e migliorare la qualità di vita di tutti. La vittoria di Pirro ne è un bell’esempio . Sicuramente è importante spiegare che Pirro, re dell’Epiro, sfidò Roma, invadendo l’Italia nel terzo secolo avanti Cristo. In una delle battaglie (quella finale) i romani persero, ma causando tante e tali perdite all’esercito di Pirro che questi fu costretto ad abbandonare la guerra. Si possono aggiungere le date, spiegare la strategia militare, i nomi dei generali romani, e tutto quanto è compreso nel testo di storia, funzionale all’età dello studente. Ma si può anche cogliere l’occasione per spiegare che la definizione di “vittoria di Pirro” è rimasta nei modi di dire per evidenziare come una vittoria può equivalere ad una sconfitta . E da qui spiegare che non esiste solo la dicotomia vittoria – sconfitta, che non è indispensabile vincere o perdere. Se c’è un contrasto, se ci sono diversi punti di vista o diversi obiettivi, si può vincere insieme. Grazie a Pirro diventa più semplice spiegare quanto sono vane alcune liti, e quanto invece si può guadagnare con una negoziazione . Attenzione! Negoziazione, e non compromesso! Quando la guerra è in atto, al massimo si raggiunge un compromesso. Ma prima che la battaglia si scateni, che la lite raggiunga l’apice, si può tendere alla negoziazione: comprensione dell’altro e delle sue priorità e scelta di un obiettivo comune. Impossibile? Difficile? Complesso! Ma quanto si vive meglio! Questo è quanto scrivevo alcuni anni fa. Oggi, mai come oggi, è fondamentale ricordare il concetto della vittoria di Pirro. Oggi si combatte per vittorie immediate, con battaglie basate fondamentalmente sulla forza. Oggi si dimentica quanto siamo interconnessi e quanto la apparente sconfitta di uno diventa, in poco tempo, la sconfitta di tutti. A me sembra che i contendenti di oggi, e uno in particolare, stia precipitando verso una vittoria di Pirro, con gravi danni per tutti.